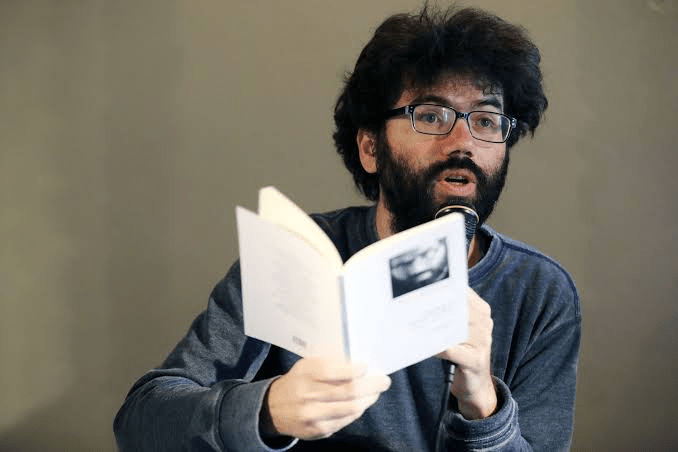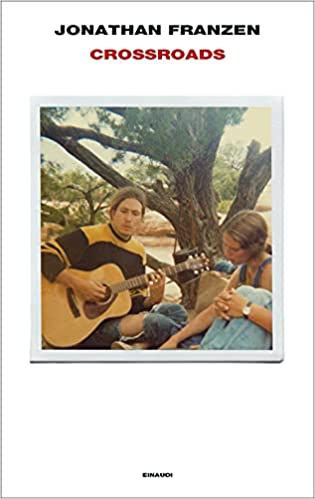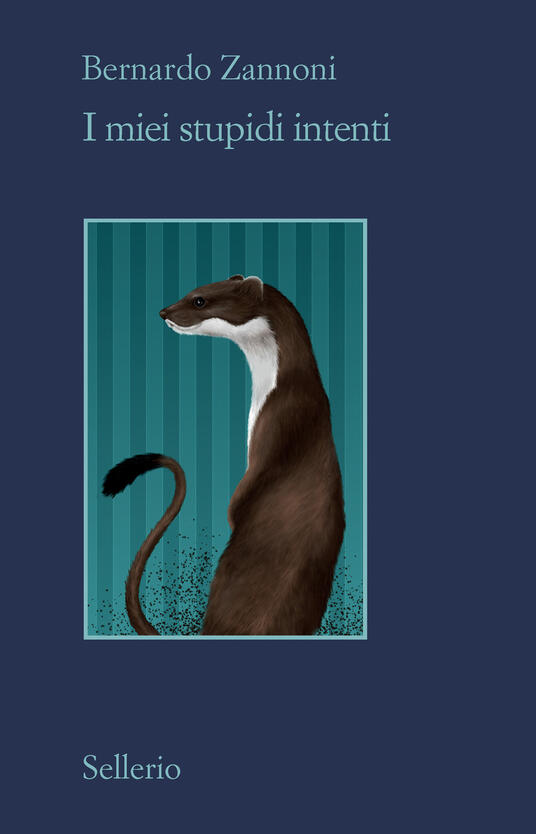Quando nel 1965, un anno dopo la precoce morte dell’autrice, viene pubblicata la raccolta di racconti Punto Omega di Flannery O’Connor, gli Stati Uniti, ancora nel pieno della guerra fredda e impantanati nel conflitto del Vietnam, sono scossi da profonde tensioni interne. La lotta per la parità dei diritti degli afroamericani è in piena fase di deflagrazione. Malcolm X è appena stato assassinato, a colpi di pistola, durante un discorso pubblico a Harlem. Martin Luther King è all’apice della sua parabola civile: ha da pochi mesi ricevuto il premio Nobel per la Pace. Il presidente americano Johnson, a marzo, ha presentato la legge sul diritto al voto che ha lo scopo di proibire la discriminazione razziale e linguistica nelle elezioni.
Martin Luther King e Flannery O’Connor sono nati entrambi, a distanza di quattro anni (1925 lei, 1929 lui), nell’assolata e arretrata Georgia della Bible belt, il profondo Sud degli Stati Uniti immortalato da William Faulkner: la Georgia dalle radici rurali e religiose, dalle sterminate piantagioni di cotone coltivate dagli schiavi afro-americani, la Georgia roccaforte della discriminazione razziale.
Flannery O’Connor trascorre in Georgia quasi tutta la sua vita, condizionata da una malattia immunitaria debilitante che si manifesta per la prima volta quando ha venticinque anni. Ma un’eccezione importante è costituita dal periodo di formazione trascorso presso la scuola di scrittura dell’Iowa, nel Midwest, nella fucina di talenti letterari che teorizza e insegna lo Show Don’t Tell magistralmente illustrato da Ernest Hemingway, e che tanto peso avrà nella narrativa di O’Connor stessa. Vive nel chiuso della fattoria di famiglia, dove viene accudita dalla madre (modello ideale di tanti personaggi femminili dei suoi racconti) e si dedica alla scrittura fino agli ultimi giorni, anima sensibile in cerca della grazia divina e, allo stesso tempo, anima tormentata, incapace di considerare conclusiva qualunque risposta terrena alla domanda di senso.
Si potrebbe in un certo senso dire che di questa Georgia, se il pastore e predicatore Martin Luther rappresenta la faccia diurna della lotta per l’affermazione dei diritti civili, la scrittrice Flannery è lo specchio notturno e letterario, quello che mostra il rovescio, la fragilità, la radice del Male e della ferita. Ma sarebbe una rappresentazione solo parziale del significato della sua opera.
Nel suo fertile sacerdozio letterario O’Connor scrive due romanzi e due raccolte di racconti, offrendoci un ricchissimo campionario di umanità sofferente. Il suo scandaglio, incentrato su una visione religiosa e cristiana dell’esistenza, ritrae il bigottismo, l’arretratezza, i turbamenti, il razzismo della popolazione bianca del profondo Sud, condizionata da un passato culturalmente ingombrante e sfidata nelle proprie intime convinzioni dal vento della modernizzazione, da quei «negri [che] il cotone non vogliono raccoglierlo più», che agiscono da spettro della popolazione bianca in molti dei suoi racconti. Però lo fa, questa la peculiarità rispetto a tanti altri grandi classici del Novecento secolarizzato e ateo, in una prospettiva profondamente religiosa.
La domanda con cui il lettore moderno, allora, si accosta all’opera di O’Connor non può che essere una: come può un’autrice condizionata da una così profonda pregiudiziale religiosa concepire della letteratura universale e non parziale, cioè valida per tutti, anche per chi non crede e non postula l’esistenza di un trascendente? Può la sua letteratura risultare ambigua, sfaccettata, non confessionale e non consolatoria? Può generare, come tutti i grandi testi letterari, un surplus di senso?
Rivelazione
Una risposta a questa domanda la fornisce uno dei suoi racconti più famosi, e a nostro parere più riusciti: Revelation (Rivelazione), scritto poco prima della morte e incluso postumo nella raccolta Punto Omega.
Con un riassunto telegrafico si potrebbe dire che Rivelazione è la storia di una progressione (o, meglio, regressione) interiore, quella del crescente tormento della protagonista, la signora Turpin.
La signora Turpin è bianca, benestante, crede fortemente in Dio, sostiene la segregazione razziale e classifica gli esseri umani secondo una precisa scala gerarchica, sul cui gradino più basso ci sono i “bianchi poveri” e poi i “negri”. Vive di apparenze, osserva i modi e l’abbigliamento delle persone per attribuire loro una natura morale, ha giudizi sferzanti nei confronti di tutti. Collega la salvezza dell’anima allo status sociale, e quindi pensa, sentendosi una “giusta”, di meritare la salvezza. E’ quella che, nel Vangelo, verrebbe chiamata una farisea, anche se O’Connor non usa mai questa parola nel racconto.
Nella prima lunga scena ci vengono mostrati i coniugi Turpin che fanno ingresso nell’affollata sala d’attesa del medico e avviano una conversazione di maniera con gli altri pazienti: lui dimesso e placido, lei imponente e dominante. L’unica presenza che mette in soggezione la signora Turpin è una diciottenne brutta e grassa, che legge con cipiglio un libro intitolato Evoluzione umana. Durante il dialogo la ragazza ha modo di esternare la sua inspiegabile ostilità nei confronti della signora Turpin, fino al punto di tirarle addosso il libro e di aggredirla, dicendole una frase tremenda («torna nell’inferno da dove sei venuta, vecchia scrofa brufolosa») e venendo infine bloccata e sedata dal medico.
Al ritorno a casa la signora Turpin è turbata. Non riesce a dimenticare il volto cattivo della ragazza, sospetta che sia un’emissaria dell’aldilà giunta a consegnarle un messaggio di irredimibile condanna. Scossa da una forte inquietudine, compie le azioni della routine quotidiana, fino a quando non si reca nel recinto dei maiali e non vive una tragica visione del destino delle anime: le vede in cammino, in ascesa verso il mondo ultraterreno, neri e bianchi poveri in prima fila, destinati alla salvezza, mentre la sua anima e quella di suo marito sono relegate agli ultimi posti, ardenti in mezzo alle fiamme.
Il racconto contiene, in modo esemplare, molte delle caratteristiche che hanno reso Flannery O’Connor una maestra riconosciuta della short story moderna, capace di una rigorosa e felice applicazione dello Show Don’t Tell e, insieme, di grande sapienza nel disseminare di risorse simboliche la narrazione.
Il racconto è svolto in terza persona, quasi sempre dal punto di vista della signora Turpin. Sue sono le notazioni malevole, suoi i pregiudizi feroci, suo il perbenismo bigotto e il moralismo: pensieri e frasi come «a volte la signora Turpin passava la notte a classificare la gente», «peggio dei negri», «non si poteva mai dire niente di intelligente a un negro» le appartengono intimamente. O’Connor non commenta e non giudica, sparisce dietro al personaggio, si limita a registrare dettagli e pensieri.
La connotazione agisce potentemente, ma in modo indiretto, per esempio nell’ambientazione: la sala del medico è «poco più grande di un garage», il tavolo è pieno di riviste «flosce», il posacenere «pieno di mozziconi di sigarette e di batuffoli di cotone con delle macchioline di sangue». Il vecchio in attesa è «lungo e allampanato, con le mani rugginose aperte sulle ginocchia”, ha «gli occhi chiusi come se fosse addormentato o morto, o fingesse di esserlo per non doversi alzare e offrire il posto». Un garage sporco e angusto, oggetti flosci e cadenti, resti di umanità e di sangue, ruggine e torpore (da intendersi come peccato morale), morte. Pochi elementi, ben impilati, e siamo nel pieno di quegli scenari desolati e purulenti che caratterizzano la narrativa di O’Connor.
Narrativa in cui spicca l’eccezionale orecchio per i dialoghi: ad esempio il linguaggio universale, valido a qualunque latitudine, di una coppia consolidata di coniugi di mezza età, o il tono di chiacchiera sociale della sala d’attesa, con le ostentazioni e le prese di posizione.
Notevolissima anche l’esattezza della rappresentazione della tensione interiore della protagonista: il tormentato rapporto con il sovrappeso, l’interazione con i personaggi dello studio medico e della fattoria, dove la signora Turpin si rivela accondiscendente con alcuni e liquidatoria con altri, a seconda del peso sociale. Nel dialogo a casa, il marito evita con rodata scaltrezza il confronto con lei; ancora meglio, nella scena con i «negri», Mrs Turpin prima, in un momento di debolezza, si sfoga, poi, quando loro tentano di consolarla con delle lodi sperticate, viene colta da un moto di stizza. Dall’inizio, dalla prima apparizione, il lettore accorto sospetta l’insicurezza profonda che si cela dietro la smaniosa alterigia di Mrs Turpin: la sospetta ma non ne è certo, e questo è un merito della finezza psicologica dell’autrice.
Il riferimento letterario più evidente del racconto è nel Vangelo, nella parabola del fariseo e del pubblicano (Vangelo secondo Luca), che potrebbe essere vista come un modello del racconto, ma da cui la short story si discosta in modo significativo. Mrs Turpin rappresenta la “giusta” che è convinta di vivere in modo esemplare e pensa di avere diritto alla salvezza; gli altri personaggi, quelli minori, potrebbero essere i pubblicani, ma nulla ci autorizza a pensare che vadano umilmente a battersi il petto, chiedendo perdono, come il pubblicano della parabola. E infine Dio, invece di manifestare chiaramente la propria voce, rimane nascosto: forse la visione finale di Mrs Turpin proviene da lui, ma forse è solo un’allucinazione…
Un finale ambivalente
La chiave di volta del racconto è proprio nel finale, nella potente visione dell’ascesa all’aldilà. Si potrebbe con argomenti altrettanto validi sostenere sia la tesi della visione divina, o perlomeno di un significato trascendente nascosto dietro di essa, sia la tesi antitetica dell’allucinazione di Mrs Turpin. Fedele al principio della paziente e selettiva raccolta di fatti e di dettagli, O’Connor non ci fornisce nessun indizio che sciolga il dilemma. Quindi, in questa riproposizione novecentesca della parabola evangelica, molto modernamente non è dato avere dei pubblicani umili e pentiti, né è dato avere un Dio (un senso) che riveli con chiarezza le sue intenzioni.
Una lettura del tutto psicologistica ed empiristica del racconto, a nostro giudizio lecita, potrebbe interpretarlo come uno studio narrativo sull’effetto che le predicazioni religiose producono su una personalità incerta e suggestionabile. L’invadente dominanza di Mrs Turpin verso il marito e verso gli altri personaggi, le incrollabili opinioni sul mondo, sono bastioni della fortezza eretta da lei a guardia della propria insicurezza, dei propri tremori, dei dubbi su come vivere e su come risolvere il problema della morte; e altrettanto spiegabili, in questo senso, sarebbero la tendenza a sovrainterpretare di Mrs Turpin e l’allucinazione finale, il frutto di una forte suggestione.
Questa ambivalenza, questa duplicità della lettura rende il racconto una potente esemplificazione della costitutiva ambiguità della produzione di O’Connor. E fornisce, anche, una risposta alla domanda iniziale: i racconti di O’Connor non sembrano postulare l’esistenza del trascendente, non si fondano su una visione metafisica, al contrario sembrano esplorare, con piglio rigoroso da osservatore, le manifestazioni della religiosità e le sue derive. Se il tormento religioso è presente, lo è come motore dello sguardo, come obiettivo dell’indagine: non come spiegazione o come rivelazione di senso, che non può che essere al di là dell’umanamente conoscibile.
Il grottesco di Flannery O’Connor
La narrativa di O’Connor è stata storicamente collegata al filone del gothic americano, del “grottesco”, nel senso di sovrannaturale, distorto, horror, anche se sul piano delle ascendenze letterarie si è soliti fare il nome di William Faulkner e di Eudora Welty, per le ambientazioni rurali e torbide nel profondo Sud. Sul piano formale O’Connor è uno degli anelli di congiunzione di un’ideale catena di maestri della short story che parte da Edgar Allan Poe (il gothic!), passa per Cechov e per il Joyce di Dubliners e prosegue, in un ideale passaggio di staffetta, fino ad Alice Munro, sostanzialmente coetanea di O’Connor ma, al momento della sua morte, ancora di là dall’esordio.
Il grottesco di Flannery O’Connor ha una peculiare curvatura realistica. Come si vede bene in Rivelazione, non sono presenti elementi soprannaturali, nulla è inspiegabile sul piano della razionalità empirica, la visione di Mrs Turpin può benissimo essere frutto di una suggestione. Vedere la realtà per quello che è, cioè deforme: questo è il grottesco secondo O’Connor. Una donna massiccia e priva di risorse spirituali paragonabile a una scrofa, un fatiscente studio medico che puzza di umanità, un’adolescente malata e dominata da mal digerite idee di modernizzazione, la povertà e il degrado della società. O’Connor ci accompagna, sciogliendosi dentro le vite interiori dei suoi personaggi, in un viaggio disturbante lungo una galleria di umanità dolente e ululante: anziani e bambini, sbandati e fanatici religiosi, uomini e donne astiosi e incapaci di amare, persi nelle loro ossessioni.
Una realtà ferita, un mondo deformato che non può che cercare salvezza nel riscatto religioso; riscatto che, però, rimane sul piano della domanda aperta. Tutto osservato, tutto rappresentato con abile disposizione delle scarne risorse di senso, metafore infilate per orientare la lettura ma nessuna spiegazione dirimente: passaggi come, per fare un esempio, «il sole era dietro il bosco, molto rosso, e guardava sopra la palizzata di alberi come un fattore che esamini i maiali», l’analogia che in Rivelazione porta a compimento l’inquietante parallelo tra uomini e maiali («sono più puliti di certi bambini», aveva detto Mrs Turpin all’inizio del racconto parlando dei maiali del proprio allevamento, e ora i lettori possono collegare tutti i puntini).
Considerazioni analoghe valgono per l’asciuttezza con cui O’Connor affronta temi e situazioni estremamente controversi: la segregazione dei neri, ma anche le gerarchie sociali (i «bianchi poveri» che sono l’altro bersaglio di Mrs Turpin). Il tono della scrittura non trema mai, non tradisce sbavature: non pende nella direzione della denuncia illuminata dal pulpito, che sarebbe, come si è visto, antitetica alla premesse del progetto letterario di O’Connor, ma nemmeno nella direzione, opposta, del compiacimento pruriginoso, dello scandalo aperto. O’Connor sembra semplicemente registrare uno stato delle cose, con cruda e disarmante semplicità. Sembra dire, con un impercettibile cenno di assenso: “Sì, le cose stanno così. Punto”.
Rimane, per chiudere, il problema della letteratura. In un mondo imperscrutabile, in una realtà ferita che potrebbe essere stata creata da un Dio (ma non è dato saperlo con certezza prima del valico finale), il problema del senso non può che essere oggetto di un’indagine semiotica, di uno studio dei segni, secondo i modi della letteratura. L’epifania, la manifestazione del Dio, non può che avvenire come un’epifania joyciana; scrutare il cielo alla ricerca di segni rivelatori (o, più angustamente, il soffitto, come fa Mrs Turpin: «come se sul soffitto ci fossero delle scritte incomprensibili») è come leggere le righe di un testo, alla ricerca cauta e difficoltosa di indizi provvisori. Show don’t Tell non è solo un precetto di scrittura, ma la modalità più corretta di rapporto con il divino.
Le due ossessioni di Flannery O’Connor, la religione e la letteratura, a ben guardare, si fondono in una cosa sola: due facce dello stesso medaglione grondante di sofferenza.